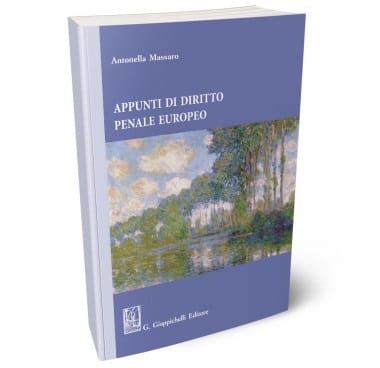La CGUE si pronuncia in tema di decisioni di diniego delle richieste di estradizione adottate da Stati membri e principio di riconoscimento reciproco

CGUE, Sezione Terza, 19 giugno 2025
Causa C‑219/25 PPU [Kamekris]
Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata, decidendo sulla domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dalla Corte di Appello di Montpellier (Francia), sulla rilevanza del principio di riconoscimento reciproco nel caso di decisioni di diniego delle richieste di estradizione adottate da Stati membri.
La questione pregiudiziale era stata posta nell’ambito di una procedura estradizionale avviata dalle autorità georgiane nei confronti di quelle francesi e avente ad oggetto la consegna di un cittadino greco e georgiano, nei confronti del quale la Corte di Appello di Bruxelles (Belgio) – paese nel quale l’estradando era stato inizialmente arrestato a fini estradizionali – aveva già respinto la richiesta di estradizione presentata dalle autorità georgiane, ritenendo che sussistessero seri motivi per temere che l’estradizione verso la Georgia avrebbe esposto l’estradando a un diniego di giustizia e a un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti.
La Corte d’appello di Montpellier sospendeva la procedura e sottoponeva alla CGUE la seguente questione pregiudiziale: «se l’art. 67 par. 3 e l’art. 82 par. 1 TFUE, in combinato disposto con gli artt.19 e 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro è tenuto a rifiutare di eseguire una richiesta di estradizione di un cittadino dell’Unione europea verso un paese terzo qualora un altro Stato membro abbia precedentemente rifiutato di eseguire la stessa richiesta di estradizione con la motivazione che la consegna della persona interessata rischierebbe di violare il diritto fondamentale di non essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti sancito dall’articolo 19 della Carta e il diritto a un processo equo sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta».
Il giudice del rinvio chiede in sostanza- si legge nella sentenza – «se l’articolo 67, paragrafo 3, e l’articolo 82, paragrafo 1, TFUE debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro è tenuto a rifiutare di estradare verso un paese terzo un cittadino di un altro Stato membro qualora le autorità di un terzo Stato membro abbiano precedentemente rifiutato di eseguire una richiesta di estradizione, proveniente da tale paese terzo e diretta all’esecuzione della stessa pena inflitta a detto cittadino di un altro Stato membro, a causa dell’esistenza di un rischio serio di violazione dei diritti fondamentali garantiti dall’articolo 19, paragrafo 2, e dall’articolo 47, secondo comma, della Carta».
La Corte prende le mosse ricordando che, «a causa della sua qualità di cittadino dell’Unione, un cittadino di uno Stato membro che circola o soggiorna legalmente nel territorio di un altro Stato membro ha il diritto di avvalersi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e rientra nell’ambito di applicazione dei Trattati ai sensi dell’articolo 18 TFUE, che contiene il principio di non discriminazione in base alla nazionalità» e che «la circostanza che un cittadino di uno Stato membro diverso da quello destinatario di una richiesta di estradizione che lo riguarda possegga anche la cittadinanza di tale paese terzo autore di detta richiesta non può impedire a detto cittadino di far valere i diritti e le libertà conferiti dallo status di cittadino dell’Unione, in particolare quelli garantiti dagli articoli 18 e 21, paragrafo 1, TFUE. Infatti, la circostanza che la persona reclamata sia simultaneamente cittadina di uno Stato membro e di un paese terzo non può privarla di tali diritti e libertà».
Ciò premesso, secondo la Corte di Giustizia, «né l’art. 67 par. 3 né l’art. 82 par. 1 TFUE possono costituire la base di un obbligo di riconoscimento reciproco riguardante le decisioni di diniego, adottate dagli Stati membri, di una richiesta di estradizione proveniente da un paese terzo».
Invero, da un lato, «l’articolo 67, paragrafo 3, TFUE dispone che “[l]’Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia”, in particolare “tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali” e, “se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali” degli Stati membri; dall’altro lato, l’articolo 82, paragrafo 1, primo comma, TFUE stabilisce che “[l]a cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, in particolare quelle di cui al secondo comma, lettera a), di tale articolo 82, paragrafo 1, ai sensi del quale “[i]l Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l’Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria”».
Dalla formulazione di dette disposizioni risulta che «esse non stabiliscono, in quanto tali, un obbligo di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie penali adottate negli Stati membri, ma si limitano a disporre che la cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione è fondata sul principio di un siffatto riconoscimento. L’articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), TFUE, si limita quindi a stabilire che il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le misure intese a definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria».
Di conseguenza, «se è vero che il diritto dell’Unione contiene vari strumenti che prevedono un obbligo di riconoscimento reciproco di talune sentenze e decisioni giudiziarie penali, è tuttavia giocoforza constatare che nessun atto di diritto dell’Unione prevede un obbligo di riconoscimento reciproco delle decisioni adottate dagli Stati membri riguardanti le richieste di estradizione provenienti da un paese terzo».
Pertanto, «il principio di riconoscimento reciproco non si applica alle decisioni di diniego delle richieste di estradizione adottate dagli Stati membri».
Del resto – si legge nella pronuncia – «per quanto riguarda il mandato d’arresto europeo disciplinato dalla decisione quadro 2002/584, la Corte ha dichiarato che tale principio impone, in presenza di una decisione di non esecuzione di un siffatto mandato adottata in un altro Stato membro a causa dell’esistenza di un rischio di violazione del diritto fondamentale a un equo processo sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta, che l’autorità dell’esecuzione di uno Stato membro al quale è stata presentata una nuova domanda di consegna dell’interessato, nell’ambito del proprio esame dell’esistenza di un motivo di non esecuzione, tenga debitamente conto dei motivi sottesi a tale decisione».
Ebbene, «per le stesse ragioni, va ritenuto che il principio della fiducia reciproca imponga – in presenza di una decisione di diniego di estradizione della persona reclamata verso un paese terzo, adottata da uno Stato membro a causa di un rischio serio di trattamenti inumani – che l’autorità competente di un altro Stato membro (destinataria di una nuova richiesta di estradizione proveniente dallo stesso paese terzo e riguardante la stessa persona), tenga debitamente conto dei motivi sottesi a tale decisione di diniego, nell’ambito del proprio esame dell’esistenza di un rischio di violazione dei diritti fondamentali».
Ne consegue, come sottolineato dall’avvocata generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, che «una decisione anteriore di diniego di estradizione, adottata in un altro Stato membro, fondata sull’esistenza di un rischio serio di violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, fa parte degli elementi di cui lo Stato membro destinatario di una nuova richiesta di estradizione deve tener conto nell’ambito del proprio esame» (ossia, «elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati che possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, da decisioni giudiziarie del paese terzo richiedente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite»).
In conclusione, la Corte ha dichiarato che «l’articolo 67, paragrafo 3, e l’articolo 82, paragrafo 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non è tenuto a rifiutare di estradare verso un paese terzo un cittadino di un altro Stato membro qualora le autorità di un terzo Stato membro abbiano precedentemente rifiutato di eseguire una richiesta di estradizione, proveniente da tale paese terzo e diretta all’esecuzione della stessa pena inflitta a detto cittadino di un altro Stato membro, a causa dell’esistenza di un rischio serio di violazione dei diritti fondamentali garantiti dall’articolo 19, paragrafo 2, e dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».