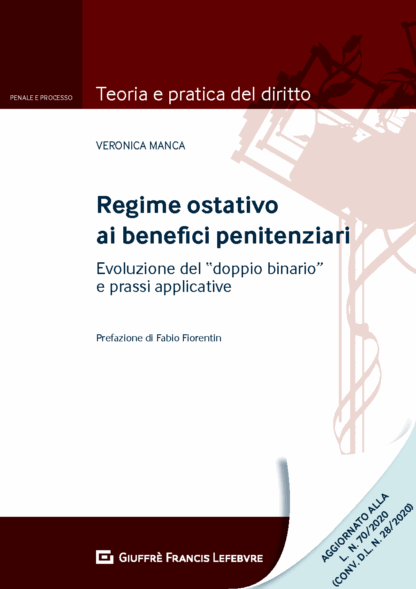Detenute madri: una stella dell’universo carcerocentrico
in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 11 – ISSN 2499-846X

presentazione a cura di Veronica Manca
Lo statuto costituzionale dell’esecuzione penitenziaria, ben espresso dalle norme di cui agli artt. 2, 3, 25, 27, co. 3 Cost., impone che al centro del rapporto detenuto-Stato si collochi l’individuo: ai sensi, infatti, dell’art. 1 O.P. si specifica che “il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”.
In altri termini, citando testualmente le parole del Presidente della Corte costituzionale, Gaetano Silvestri (in carica dal 29 settembre 2013 al 28 giugno 2014) «dignità e persona coincidono: eliminare o comprimere la dignità di un soggetto significa togliere o attenuare la sua qualità di persona. Ciò non è consentito a nessuno e per nessun motivo». Il valore supremo – logico ed ontologico – incardinato nella Costituzione e richiamato in apertura dell’ordinamento penitenziario è rappresentato, infatti, dal binomio “libertà-dignità”, che pervade la Costituzione e tutto l’ordinamento italiano: gli artt. 2 e 3 della Costituzione sono, quindi, «espressione di valori metagiuridici, legati alla solidarietà e alla dignità della persona umana, vere e proprie “ancore normative” dei diritti inviolabili riconosciuti all’individuo in quanto tale, a prescindere da qualsiasi connotazione soggettiva o, in questo caso, da ogni valutazione della sua condotta».
Che la dimensione affettiva sia parte integrante del rispetto della dignità della persona detenuta, del resto, è evidenziato anche dallo stesso ordinamento penitenziario, il quale, in numerose disposizioni, richiama la centralità della sfera affettiva del detenuto e chiarisce come il mantenimento dei rapporti con la famiglia all’esterno possa rappresentare un elemento positivo di valutazione all’interno del percorso trattamentale: i legami familiari, infatti, sono un parametro su cui modellare il processo di individualizzazione (a prescindere, peraltro, da ogni valutazione di tipo premiale). La rilevanza della dimensione familiare è, ad esempio, segnalata dall’art. 1, co. 6 O.P., a mente del quale: “Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”. Ancora più chiare sono poi le disposizioni di cui agli artt. 15 e 28 O.P., rubricate “Elementi del trattamento” e “Rapporti con la famiglia” o ancora l’art. 45 O.P., il quale prescrive la necessità che “il trattamento dei detenuti e degli internati sia integrato da un’azione di assistenza alle loro famiglie. Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale […]”.
Se, quindi, a livello di principio, le disposizioni dell’ordinamento penitenziario sembrano non precludere la piena attuazione della dimensione affettiva, numerosi sono gli ostacoli normativi, applicativi e fattuali che impediscono, in sostanza, una completa fruizione della sfera affettiva da parte del detenuto (in carcere) e dei familiari (all’esterno): basti pensare al controllo a vista da parte della polizia penitenziaria, al disagio che accompagna il familiare all’atto di ingresso in carcere, al contrapposto sentimento di fallimento misto a vergogna in cui vive perennemente il detenuto al momento del contatto con la propria famiglia, alla necessità di ripristinare una normalità negata dalla “anormalità” della detenzione, che spesso conduce – sul versante della sessualità – all’autoerotismo (fisico o virtuale), all’omosessualità indotta, ovvero alla completa rinuncia e privazione del contatto fisico (non sconosciuti alla prassi sono, infatti, i c.d. “matrimoni bianchi”, celebrati e non consumati). Ad oggi, l’unica possibilità di vivere la propria affettività è data dalla concessione del permesso premio di cui all’art. 30 O.P. in stato di libertà, il quale, comunque risulta essere uno strumento trattamentale che può essere concesso solo se sussistono i requisiti soggettivi (l’assenza di pericolosità e la buona condotta) e oggettivi connessi al quantum di pena espiato. Di fatto, quindi, anche se, sul piano dei principi generali informanti l’esecuzione penitenziaria, si asserisce che la dimensione affettiva prescinda dai meccanismi premiali, perché è insita nel processo di individualizzazione della pena e del trattamento penitenziario, in sostanza, la possibilità di esercizio della stessa finisce per essere subordinata alla valutazione positiva della buona condotta intramuraria.
Su queste premesse, l’attenzione sul tema deve rimanere sempre costante e per questo – in attesa della pubblicazione dei lavori della Call for papers “Affettività: un binomio (im)possibile?” – riteniamo indispensabile occuparci in prima persona della diffusione, sensibilizzazione ed (in)formazione di progetti, iniziative, ricerche e contributi scientifici in tema di diritto all’affettività in e dal carcere.
***
Il breve contributo dell’autore tenda di fare il punto rispetto ai gravi episodi verificatisi nella Casa circondariale – sezione femminile di Rebibbia che ha visto la morte di due bambini.
Come citare il contributo in una bibliografia:
D. Monni, Detenute madri: una stella dell’universo carcerocentrico, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 11