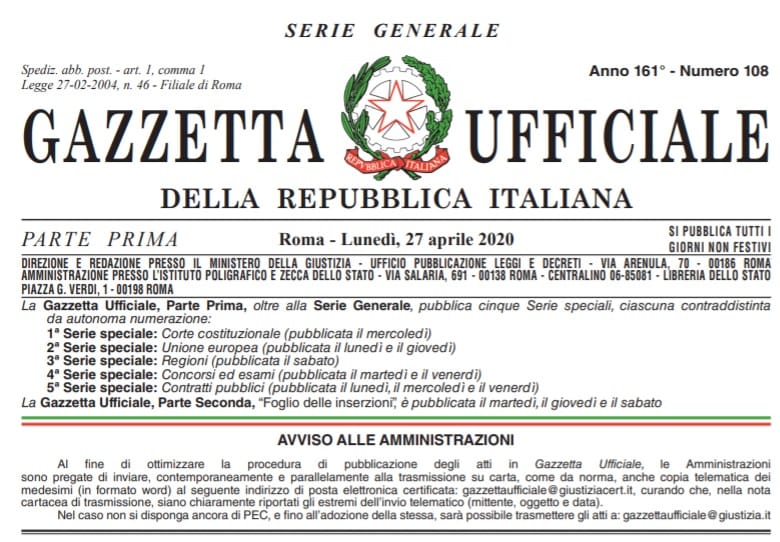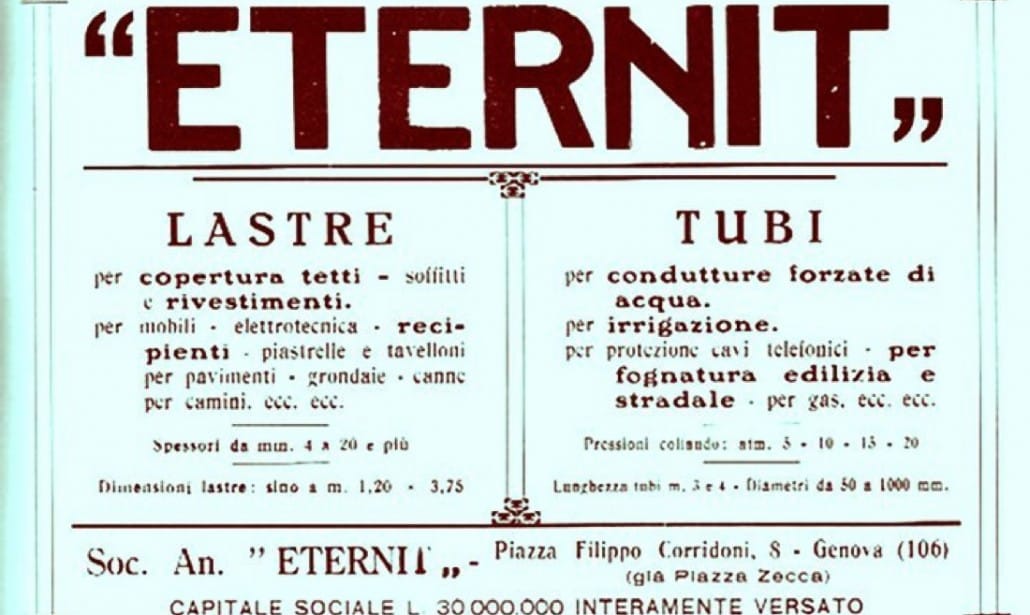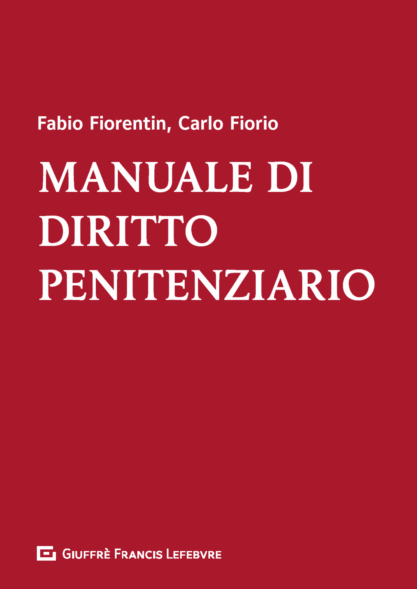Proporzionalità della pena e sequestro a scopo di estorsione: depositata la sentenza della Corte costituzionale (n. 113/2025)

Corte costituzionale, 18 luglio 2025, n. 113
Presidente Amoroso, Relatore Viganò
Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili o infondate le questioni – sollevate dalla Corte di assise di Teramo – dell’art. 630, primo comma, del codice penale «come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 59 del 21.3.1978, convertito con modificazioni nella legge n. 191 del 18 maggio 1978 (Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati)», nella parte in cui prevede, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, la pena della reclusione da venticinque a trent’anni in luogo della reclusione da dodici a venticinque anni.
Pubblichiamo di seguito il testo del comunicato stampa:
Proporzionalità della pena e sequestro a scopo di estorsione: il giudice ha già gli strumenti per applicare pene adeguate alla concreta gravità del fatto.
Non è incostituzionale la pena della reclusione da venticinque a trent’anni prevista per il sequestro di persona a scopo di estorsione, perché il giudice dispone di vari strumenti per adeguare la risposta sanzionatoria alla concreta gravità del fatto, in conformità al principio costituzionale di proporzionalità della pena.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza numero 113, depositata oggi, con cui ha ritenuto non fondate le questioni sollevate in proposito dalla Corte d’assise di Torino, in un caso concernente la responsabilità di tre imputati accusati di sequestro estorsivo per avere per breve tempo privato le vittime della libertà personale, allo scopo di ottenere pagamenti di somme tra i 100 e i 320 euro quale corrispettivo di prestazioni sessuali, che le vittime ritenevano non dovute nella convinzione che gli incontri fossero di natura gratuita.
La Consulta ha ricordato che la pena prevista per il sequestro a scopo di estorsione, superiore persino a quella stabilita per l’omicidio non aggravato, è stata innalzata agli attuali livelli di eccezionale asprezza a seguito dell’ondata di sequestri che negli anni settanta avevano afflitto il nostro paese, e che erano caratterizzati tra l’altro dalla lunghissima durata della privazione della libertà personale delle vittime, da richieste di riscatto elevatissime e da gravi pericoli per la vita stessa degli ostaggi, che non di rado venivano uccisi dai loro sequestratori.
Già nel 2012, però, la Corte aveva ritenuto manifestamente sproporzionata la pena minima di venticinque anni di reclusione nel caso di sequestri estorsivi di minore entità, e aveva pertanto introdotto la possibilità, per il giudice, di ridurre sino a un terzo la pena (dunque, fino a un minimo di sedici anni e otto mesi di reclusione).
Con la sentenza odierna, la Corte ha osservato che se la pena risulta comunque eccessiva rispetto alla concreta gravità del fatto, anche se ridotta di un terzo, il giudice può comunque utilizzare il principio costituzionale di proporzionalità della pena quale criterio che orienta l’interpretazione e l’applicazione della legge penale, ed evitare così di applicare una pena del tutto sproporzionata alla gravità del fatto. In particolare, il giudice dovrà valutare con speciale attenzione se i fatti accertati raggiungano effettivamente la soglia di gravità che giustifica, nella valutazione del legislatore, la previsione di una pena così severa, o se invece non si configurino i reati
di sequestro di persona “semplice” e, secondo i casi, rapina o estorsione: reati che comportano l’applicazione di una pena “comunque adeguata alla gravità del fatto commesso e ragionevolmente dissuasiva, e però contenuta entro i limiti della proporzione”.
Una simile conclusione, ha scritto la Corte, non si pone in contrasto con il principio di legalità. Infatti, tale principio vieta di applicare una norma penale oltre i casi da essa previsti, ma non si oppone a che il giudice possa interpretare restrittivamente una disposizione incriminatrice, escludendone l’applicazione ogniqualvolta risulti che il fatto concreto sia del tutto diverso dai fenomeni criminosi che il legislatore aveva inteso colpire con una sanzione così severa.
Roma, 18 luglio 2025