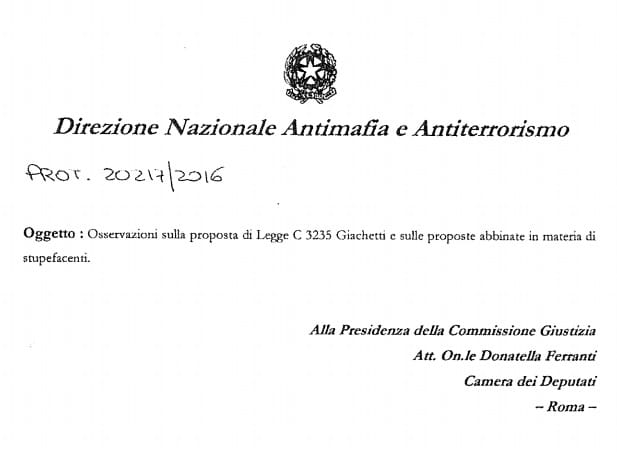Osservazioni a prima lettura sulla sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza penale della commercializzazione di prodotti derivati dalla Cannabis Sativa light
in Giurisprudenza Penale, 2019, 7-8 – ISSN 2499-846X
di Carlo Alberto Zaina e Giacomo Bulleri

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 10 luglio 2019 (ud. 30 maggio 2019), n, 30475
Presidente Carcano, Relatore Montagni
1. Le motivazioni della sentenza n. 30475/2019 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno elaborato il seguente principio di diritto: “La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio, resina ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte al Catalogo comune delle specie delle piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati della predetta coltivazione che possono essere commercializzati”, sicchè la cessione, la vendita, e in genere la commercializzazione al pubblico dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, son condotte che integrano il reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 4 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano in concreto privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività”.
La Corte parte dal presupposto di dover dissipare un “apparente contrasto” tra il T.U. Stupefacenti e la L. n. 242/2016.
Con tale finalità la Corte ricostruisce l’ambito del T.U. Stupefacenti rilevando come, in sostanza, la “cannabis ed i prodotti da essa ottenuti” siano inclusi in tabella II dall’art. 14, c. 1, lett. b) del T.U. e che tale tabella II include tra le sostenze vietate “cannabis (foglie e infiorescenze), cannabis (olio) e cannabis (resina)”, nonché le preparazioni contenenti dette sostanze in conformità alle modalità di cui alla tabella dei medicinali.
L’art. 26 costituisce poi l’eccezione consentendo la coltivazione di cannabis “esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli indicati dall’art. 27, consentiti dalla normativa dell’Unione Europea”. L’art. 73 poi vieta ogni forma di produzione, cessione, impiego di cannabis prevedendo tali condotte come reato. Per le Sezioni Unite, insomma, la cannabis è unica e rientra tra gli stupefacenti senza distinzioni ad eccezione delle destinazioni di cui all’art. 26.
In tale contesto si inserisce la L. n. 242/2016, la quale recepisce la medesima impostazione dell’art. 26 e prevederebbe all’art. 2 una serie di destinazioni di utilizzo della canapa coltivabile lecitamente che per la Cassazione sono tassative ed inderogabile.
Ergo ciò che non è incluso nell’art. 2 costituisce reato, ivi compresa la commercializzazione di fiori, foglie, oli e resine in quanto fuori dall’ambito della L. n. 242/2016.
Fin qui sembrerebbe tutto semplice se non fosse per la necessità di definire con chiarezze il rapporto di regola/eccezione, che risulta palesemente carente in 2 punti:
1) Sono eccettuate dal T.U. Stupefacenti le destinazioni per produzioni di fibre “o per altri usi industriali consentiti dall’Unione Europea”. Ma quali sono tali altrui usi industriali?
Ciò che appare estremamente lacunoso è la ricostruzione ed i riferimenti alla normativa comunitaria.
Le Sezioni Unite hanno menzionato tutta una serie di norme (Direttiva 2002/53/CE del 13.06.2002, Reg (UE) n. 1307/2013 del 17.12.2013 ed il Reg (UE)n. 639/2014), ma ha omesso i riferimenti alle norme che più di ogni altra caratterizzano la canapa a livello comunitario e ne forniscono una chiara definizione ed il conseguente corretto inquadramento giuridico, ossia:
a) il TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) 2012/C pubblicato in Gazz. Uff n. C 326 del 26/10/2012, che nell’allegato I, alla lettera a) prodotti agricoli cui si applicano le disposizioni del medesimo Trattato, ricomprende la “canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata”.
b) il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/220 della Commissione del 3.02.2015 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nell’Unione europea menziona espressamente la “canapa” tra le piante industriali.
Tale “omissione” rappresenta una lacuna estremamente grave dal momento che costituisce una delle eccezione indicate dalle stesse SS.UU. alla generica applicabilità della disciplina del T.U. Stupefacenti ossia “gli altri usi consentiti dalla normativa dell’Unione europea”.
Appare evidente che, anche partendo dal quadro delineato dalle SS.UU. si delinei un ambito derogatorio al T.U. Stupefacenti (previsto dallo stesso art. 26 così come dalla L. n. 242/2016) per quanto attiene agli usi consentiti dalla normativa UE ossia: prodotto agricolo e pianta industriale, senza alcuna limitazione a parti della pianta.
Le Sezioni Unite paiono aver invece optato per una interpretazione restrittiva della portata della normativa nazionale e comunitaria ricalcando il modello francese che, con un Decreto del 1990, limita l’uso della canapa ai soli semi e fibre.
Ma con la differenza che la Francia prevede una esplicita norma di legge in tal senso che l’ordinamento italiano non prevede. La L. n. 242/2016 sostiene e promuove la filiera della canapa sativa non solo di parti di essa.
Ma al di là di tali considerazioni ciò che preme rilevare è che, in ogni caso, tali normative o interpretazioni restrittive delle norme UE determinano in concreto un ostacolo alla libera circolazione delle merci e, conseguentemente, un rischio di censura da parte della UE al pari di quanto subito dalla legislazione svedese.
La Corte di Giustizia Europea, infatti, con la decisione n. 462/01 (caso Hammarstein) ha rilevato, da un lato, che i rischi per la salute umana determinati dall’uso di stupefacenti sono stati presi nella dovuta considerazione dal legislatore europeo e, dall’altro, che i regolamenti disciplinanti l’organizzazione comune del mercato nel settore della canapa “devono essere interpretati nel senso che sono contrari ad una legislazione nazionale che ha per effetto di vietare la coltura e la detenzione della canapa industriale contemplati dai predetti regolamenti”.
Ciò determina una plausibile inibizione de facto di ogni normativa nazionale contrastante con le disposizioni comunitarie in materia di canapa industriale in quanto potenzialmente dannosa per il mercato economico comune e per la libertà di iniziativa economica privata.
2) La configurabilità del reato è comunque subordinata all’offensività della condotta che dovrà essere valutata nel caso in concreto dal Giudice.
Ciò che quindi emerge dalla sentenza in commento è quindi che la cd. canapa industriale (che le Sezioni Unite confondono in toto con la “cannabis light”) deve essere destinata alla produzione di fibre o altri usi industriali consentiti dalla normativa comunitaria, ma che non si traducono (come erroneamente indica la Corte) nei soli semi e fibre, ma nell’intera pianta, definita quale “Pianta industriale” e “prodotto agricolo”.
Caso mai eventuali limitazioni all’uso di parti della pianta possono sussistere in specifiche normative di settore (ad esempio nell’alimentare in virtù delle previsioni del Novel Food Catalogue), ma non sono previste tout court dalla normativa UE.
Ciò che è vietato – e non potrebbe essere diversamente – è coltivare per produrre stupefacenti.
Le stesse Sezioni Unite affermano che “la norma incriminatrice, infatti, riguarda la commercializzazione dei derivati della coltivazione – foglie, inflorescenze, olio e resina – ove si concentra il tetraidrocannabidiolo”
Ciò che è vietato, per la Cassazione, è commercializzare, produrre, trasformare la cannabis coltivata per produrre sostanze stupefacenti, non potendosi applicare ai prodotti derivati le soglie di THC previste dall’art. 4 della L. n. 242/2016 (0,2% e 0,6%) che, invece sono applicabili soltanto all’agricoltori e costituiscono limiti “in campo” della pianta.
Tale soluzione, in realtà, è la medesima del modello inglese ove i limiti di THC nei prodotti finiti non sono rapportati al limite comunitario dello 0,2%, bensì sono determinati in 1 mg per confezione, per “dose individuale” (tablet, capsule ecc.).
Ciò detto resta da chiarire quale sia il limite applicabile in Italia per determinare la punibilità della condotta, nonché la sorte di tutti quei prodotti che invece non hanno alcuna efficacia drogante.
Sul punto, sulla base della normativa comunitaria sopra richiamata e singolarmente “omessa” dalle Sezioni Unite, non si può che giungere alla seguente conclusione:
L’ambito di applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite riguarda – per espresso riferimento – la commercializzazione “al pubblico” dei derivati della cannabis quali fiori, foglie, olio e resina eccetto che:
I) Per le destinazioni di cui all’art. 2 della L. n. 242/2016 ossia:
- a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
- b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita’ artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
- c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
- d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
- e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
- f) coltivazioni dedicate alle attivita’ didattiche e dimostrative nonche’ di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
- g) coltivazioni destinate al florovivaismo.
Tali prodotti erano e sono, pertanto, pienamente leciti.
E’ plausibile, pertanto, anche sulla base della ricostruzione effettuata dalla Corte di Cassazione, ritenere lecita l’attività di trasformazione della canapa (espressamente prevista dalla L. n. 242/2016) per le destinazioni sopra elencate.
Ad esempio, non potrà ricadere nella norma penale l’attività di trasformazione di canapa per produrre alimenti, cosmetici o gli altri usi indicati.
Lo stesso per ciò che attiene la produzione e vendita di piante e fiori ornamentali, in quanto evidentemente frutto delle coltivazioni florovivaistiche.
Sul punto, a parere dello scrivente, la Corte ha voluto intervenire con fermezza escludendo la commercializzazione di fiori, resine, foglie ed olii con destinazioni “tecniche” o “collezionistiche” in quanto, da un lato, non previste dalla L. n. 242/2016 e, dall’altro, rientranti nelle condotte punibili ex art. 73 T.U. Stupefacente qualora abbiano efficacia drogante.
In sostanza, è percepile l’intento delle Sezioni Unite di “reprimere” il fenomeno della cd. cannabis light, ma non bisogna fare confusione tra il fenomeno della “cannabis light” e gli altri prodotti ottenibili dalla filiera.
Se da un lato la legge non prevede di vendere infiorescenze per “uso tecnico” (ma neanche lo vieta), dall’altro, certamente la Cassazione non può escludere le destinazioni lecite previste dalla legge o dalla normativa UE. E tra queste il florovivaismo, all’interno del quale sicuramente rientra l’attività di produzione e vendita di piante e fiori ornamentali, in quanto di per sé, proprio perché ornamentali (quindi destinate ad adornare una casa o un giardino) non sono destinate ad essere ingerite o consumate in alcun modo; ergo non possono produrre alcun effetto drogante.
Del pari anche i cannabinoidi non psicoattivi (CBD, CBG, CBN, CBC ecc.) non avendo alcuna efficacia drogante o psicotropa si ritiene possano essere prodotti ed ottenuti per trasformazione dalla canapa purchè destinati alle finalità di cui all’art. 2 della L. n. 242/2016 sopra elencati.
Del resto, non può essere prevista una limitazione a priori di tutti gli oli o degli estratti che, invece, hanno un loro spazio di utilizzo tra le destinazioni di cui all’art. 2 oltre che essere menzionati “oli” dalla lett. b) della medesima norma.
II) Le destinazioni per la produzione di fibra o per gli altri usi industriali consentiti dalla normativa comunitaria.
E sul punto, come sopra esposto, la normativa comunitaria parla di “canapa” non prevedendo limiti all’uso di parti della pianta.
Al contrario sussistono limitazioni all’uso di parti della pianta in specifiche normative di settore, ad esempio nella normativa alimentare come peraltro espressamente indicato dal riferimento di cui all’art. 1, lett. a) della legge.
Ed è a queste che occorrerà fare riferimento per valutare la conformità di un prodotto alle disposizioni legislative, ossia alle regole di produzione, fabbricazione, controlli qualità, confezionamento ed eventuali limitazioni specifiche per la cannabis ed i derivati e/o la presenza di particolari limiti di THC (ad esempio, a titolo esemplificativo, per gli alimenti sussiste un limite derivante dall’inclusione del cannabinoidi tra i Novel Food, sussistono in Italia limiti all’uso dei soli semi ed olio da seme per quanto attiene agli integratori alimentari, un ulteriore limite è rappresentato dai valori di THC negli alimenti che devono ancora essere stabiliti in maniera uniforme in tutto il territorio UE; per i cosmetici il limite principale è l’assenza di soglie di tolleranza per il THC, al di là delle ulteriori questioni pendenti circa il CosIng List).
Ma rispettando tali indicazioni non si ravvisano limiti di legge per coltivare canapa e trasformarla in tali prodotti in cosmetici o altre destinazioni di cui all’art. 2.
L’attività di trasformazione, infatti, è quella che maggiormente denota e caratterizza quelle finalità industriali o meglio quegli “altri usi industriali” che sono previsti sia dalle norme comunitaria sia dalla L. n. 242/2016, ma che certamente non si possono limitare a prescindere ai soli semi e fibre.
***
Invero, la decisione delle SSUU era assai attesa anche perché finalizzata a spiegare come dirimere importanti riflessi penalistici connessi con il commercio delle infiorescenze e, più in generale, dei derivati della canapa sativa L, quali foglie, resine ed oli.
Si deve, purtroppo, rilevare che, sotto questo specifico profilo, l’esame delle motivazioni, depositate il 10 luglio, non rende certo più chiaro e più agevolmente comprensibile l’intervento del giudice di legittimità, già sintetizzato nella comunicazione n. 15 (il dispositivo) pubblicata nell’immediatezza dell’esito dell’udienza del 30 maggio u.s. .
In primo luogo, infatti, rispetto all’ originario testo («la commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto, integrano il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, dpr 309/1990, le condotte di cessione, vendita e, in genere, commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante».) è stata aggiunta la frase “secondo il principio di offensività”.
E’ opportuno osservare che questa precisazione non sposta sul piano sostanziale minimamente i termini del problema e della sua soluzione.
Il principio di offensività, infatti, nell’ottica del decisum del Supremo Collegio, viene a coniugarsi con la valutazione della concreta efficacia drogante del prodotto, parendo avere, in linea teorica, funzione di rafforzamento di quest’ultimo concetto.
In realtà, sia il richiamo all’offensività, che l’uso dell’aggettivo “concreto”, non producono specifici ed auspicati effetti additivi, di carattere ermeneutico rispetto alla nozione di “efficacia drogante”, che rimane un mero enunziato astratto. Già di per sé, l’uso dell’aggettivo “concreto” pare superfluo per la elementare considerazione che la sussistenza dell’efficacia drogante del prodotto o è oggettivamente ravvisabile, oppure non lo è e non richiede espressioni rafforzative. Sarebbe servita da parte delle SSUU, piuttosto che vaghe e generiche locuzioni di principio, come si vedrà infra, l’indicazione di criteri definitori e probatori precisi.
Si osserva, poi, che il richiamo al carattere dell’offensività della condotta – quale categoria specifica dell’antigiuridicità – risulta citazione più pertinente rispetto alla condotta di coltivazione (quella ricadente come illecita nella previsione dell’art. 73 dpr 309/90), che a quella esaminata in questa sede.
Il concetto di offensività, infatti, si propone come sintesi giuridica che, per la sua operatività (od inoperatività) ricomprende tutta una serie di paradigmi, che a quella in esame. Non a caso, le SSUU introducono nella trattazione, la nozione di offensività, muovendo dall’esame della condotta di coltivazione (illecita), attraverso il richiamo alla nota sentenza n. 28605 del 24.4.2008 (anch’essa SSUU), per, poi, assumere l’accertamento di questa specie dell’antigiuridicità, come regola di carattere generale e risolutivo.
Ma, al di là della non pertinenza del riferimento alla coltivazione illecita (situazione completamente differente dal commercio di derivati della canapa sativa L) così non può essere, a meno che non si faccia derivare il concetto di offensività da un parametro sufficientemente certo e, comunque, privo di astrattezza. La Corte, invece, rimane (volutamente?) in una situazione di vaghezza, di limbo, ribadendo, più volte e con accenti di natura monocorde, il monito che il commercio dei derivati della cannabis sativa L integra ex se la fattispecie criminosa di cui all’art. 73 co. 4 dpr 309/90.
La ragione di questa reiterata ammonizione riposa – ad avviso del Collegio – in una duplice ragione di carattere lessicale.
Da un lato, è evidenziata la circostanza che l’emanazione della L. 79/2014 (conversione del dl 36/2014) ha modificato il testo della tabella II, cui fa obbligatorio riferimento l’art. 14 dpr 309/90, eliminando la parola “indica” (prevista a fianco di cannabis, quale specificazione della sostanza vietata). Dall’altra, si afferma che la tabella II, citata, non riporta alcun riferimento alle concentrazioni di THC nel prodotto posto in commercio.
In relazione al primo argomento, si deve rilevare che esso, pur nella sua formale correttezza, non tiene conto del valore di deroga (se non addirittura di rottura) della previsione dell’art. 1 L. 242/2016 che ha posto la canapa sativa L in un contesto del tutto ultroneo rispetto al recinto penale di cui al dpr 309/90.
Relativamente alla seconda osservazione, essa non tiene conto del valore puramente esemplificativo dell’indicazione, posto che pur nell’assenza formale di indicazioni specifiche di livelli penalmente rilevanti di THC, opera il parametro della soglia di efficacia drogante (cui proprio i supremi giudici si richiamano)[1].
Ad ogni buon conto, una volta preso atto della traslazione, seppur con motivazione tutt’altro che convincente (anche per altre ragioni che potranno essere vagliate e criticate in altre occasioni), dell’attività di commercializzazione di infiorescenze (et similia) dalla sfera del lecito (L. 242/2016) a quella dell’illecito (dpr 309/90), specifica rilevanza ha assunto la necessità di conferire reale valore e significato alla locuzione efficacia drogante del prodotto, contemplata dalle SSUU quale eccezione al regime di sanzionabilità penale del commercio.
Sullo specifico punto, si deve, però, riconoscere che le SSUU non offrono quelle linee guida, atte all’identificazione ed alla corretta applicazione del principio in questione, che, invece, sarebbe stato legittimo e naturale attendersi.
I supremi giudici sostengono, infatti, che sia insufficiente il solo esame del valore della percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, dovendosi, invece, verificare “l’idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante” .
Ribadiscono, poi, che “occorre verificare la rilevanza penale della singola condotta, rispetto alla efficacia drogante delle sostanze oggetto di cessione”.
La SC precisa, poi, che il reato è configurabile – per giurisprudenza consolidata – anche in presenza di cessione di dosi inferiori anche a quella media singola del DM 11.4.2006, e che “è necessario dimostrare, con assoluta certezza che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio, o comunque oggetto di cessione, sia di entità tale da potere produrre in concreto un effetto drogante”.
Le considerazioni che precedono introducono due riflessioni.
In primo luogo, si osserva che non vi è inversione dell’onere della prova e che, pertanto, deve essere sempre l’accusa a dimostrare l’illiceità del prodotto. Questo aspetto è fondamentale sul piano procedimentale, con particolare riferimento alle cd. regole di ingaggio da seguire da parte delle ff.oo. in sede di perquisizione (sia di iniziativa, che su decreto dell’AG).
Spiace, quindi, che la Corte di Cassazione non abbia, neppure incidentalmente, ritenuto di soffermarsi su un tema decisivo, (quello delle modalità dell’eventuale sequestro) perché esso, in fin dei conti, è il tema genetico che ha dato origine al giudizio cautelare incidentale (promosso dal PM di Ancona per la mancata convalida da parte del Gip del sequestro di urgenza ex art. 321 ter c.p.p.) pervenuto all’attenzione ed alla decisione delle SSUU.
E’, infatti, evidente che, alla luce di quanto precede, ogni sequestro effettuato tout court, in maniera indiscriminata su tutti i prodotti che possano essere ricoverati in un pubblico esercizio, oggetto di perquisizione, deve intendersi come illegittimo (e deve essere annullato l’eventuale relativo provvedimento di convalida), perché gli inquirenti, all’atto dell’accesso non possiedono la prova positiva dell’illiceità del prodotto.
D’altronde è pacifico che il fumus del sequestro non può fondarsi su mere presunzioni.
Un eventuale sequestro presuppone, quindi:
- il compimento ed il completamento di procedure di accertamento tossicologico su campioni significativi (per quantità e qualità) dei prodotti investigati, che abbiano sortito un esito tale da dimostrare la presenza di principi attivi idonei a produrre effetto drogante (sul piano percentile e sul piano dell’effettivo peso di ogni singola confezione),
- un esito che dimostri che i prodotti analizzati contengono un THC di livello superiore alla misura dello 0,5% e comunque di un peso – espresso in milligrammi – idoneo a produrre effetto drogante (come si dirà massimo 10 mg).
In secondo luogo, si deve osservare che il tenore delle indicazioni metodologiche, cui opera riferimento la S.C., con il reiterato riferimento a singoli casi, paiono introdurre profili di impropria soggettivizzazione, al fine di pervenire all’identificazione dell’efficacia drogante del prodotto.
Dalle locuzioni riportate in sentenza, l’opzione di rapportare, di volta in volta, l’efficacia drogante del prodotto al caso concreto, non si potrebbe addirittura, escludere anche il ricorso all’uso di criteri non oggettivi ed invero fortemente personalizzati (come ad esempio quello di ricavare la efficacia drogante del quantitativo di THC dal rapporto della sostanza attiva con le caratteristiche morfologiche dell’assuntore).
Ed è questo ulteriore passaggio atto a creare incertezza.
In realtà anche l’implicita delegazione che la Corte di legittimità pare rilasciare al giudice di merito. per dirimere, questione per questione, il problema, necessita l’utilizzo di parametri precisi e non già di quelle soluzioni astratte od empiriche che le SSUU prospettano. Appare, quindi, evidente il limite del ragionamento trasfuso in sentenza, che non offre una soluzione chiara che si caratterizzi per costanza e coerenza, atteso, inoltre, che i giudici ricusano (ed omettono di considerare) le metodiche funzionali alla prova, adottate da oltre trent’anni sia dalla stessa Corte, che dai giudici di merito.
La situazione delineata impone la stringente necessità di riempire di contenuti concreti l’indicazione delle SSUU e di adottare paradigmi, che, in attesa di futuri interventi normativi (se mai ci saranno) fissino con sufficiente chiarezza la linea di discrimine fra non drogante e drogante. Come detto, sin dal 1989 si è verificata una iniziale convergenza fra studi tossicologici e giurisprudenza, che ha portato ad individuare la percentuale di THC dello 0,5% come limite oltre il quale si concretizza l’effetto drogante.
A riscontro di quanto affermato deve essere citato, infatti, il testo LODI, MAROZZI, BERTOLI e MARI, Trattato di Tossicologia forense, Ed. libreria Cortina Milano ove si afferma testualmente “Tenuto conto che la quantità massima di canapa reperita nelle sigarette risulta di gr. 1 si ritiene che la percentuale di THC necessaria perché si possa parlare di canapa stupefacente sia identificabile in quella idonea a garantire un contenuto di THC nella sigaretta di almeno 5 mg. e corrisponda quindi allo 0,5%”.
Ed ancora va richiamato un altro passaggio del trattato di Tossicologia forense dove si legge “per qualificare come stupefacente una cannabis sarà dunque necessario ritrovare i tre cannabinoidi ed una percentuale di THC tale da attribuire al prodotto un certo grado di psicoattività (da circa 0,5 in su)”.
Si precisa, inoltre, che tale limite minimo è stato riaffermato da studi della Fondazioneveronesi.it. Invero, la valenza del dato percentile, considerato in sé, è stata sorprendentemente e discutibilmente sminuita dalla Corte (“ciò che occorre verificare non è la percentuale di principio attivo c0ntenuto nella sostanza ceduta”). Una valutazione più completa e ponderata (che non può azzerare i dati scientifici sopra richiamati) induce, invece, a ritenere che l’accertamento del dato percentuale debba essere ritenuto un punto di partenza nell’investigazione scientifica.
Consegue da questa premessa che è plausibile, non tanto esclude a priori, quanto completare il dato percentile con un ulteriore utile elemento, che, ad avviso di chi scrive, perfeziona il concetto di efficacia drogante. Esso attiene al peso della dose di THC necessaria, per produrre reali effetti droganti, che la comunità scientifica ha collocato in una forbice compresa fra i 5 ed i 20 mg.
Invero, non vi è unanimità fra gli studiosi di tossicologia forense, in quanto svariate sono le posizioni assunte, le quali coprono tutto l’arco che va dal minimo di mg. 5 al massimo di mg. 25, che è pari alla dose media singola prevista dalle tabelle allegate al dpr 309/90.
La S.C. esclude espressamente che il limite della dose media singola (mg. 25) possa essere preso a paradigma, costituendo quantità che può apparire comunque superiore ai limiti oltre i quali l’effetto drogante si manifesta.
Ed allora il giudice di merito metodologicamente dovrà ripiegare, sempre comunque su dati scientifici (sia percentuali, che ponderali) ricorrendo a perizia tossicologica che si incentri sui due parametri:
- della percentuale di THC[2],
- del peso del THC contenuto nella dose espresso in milligrammi.
Con riferimento all’attività di indagine scientifica, è comune esperienza quella per cui è agevole riscontrare che il consulente di ufficio o della Procura individui usualmente la dose idonea a produrre efficacia drogante in un range che si aggira sui 10/15 mg di THC.
Dunque, la soglia oltre la quale può ragionevolmente essere collocato il cd. effetto drogante del THC deve certamente superare il limite percentuale dello 0,5%.
Per quanto, invece, attiene al peso della dose di THC espresso in mg., in attesa di certezze assolute di sorta, esso va collocato prudenzialmente attorno ai 10 mg.
Quanto precede, conferma i dubbi avanzati in relazione alla circostanza che la lettura della motivazione della sentenza delle SSU, commentata in questa sede, non abbia affatto e realmente chiarito (come invece avrebbe dovuto) i termini della questione, ma abbia piuttosto, introdotto nuove possibili perplessità, cui si è fatta menzione.
La singolare astrattezza della posizione assunta dalla SC che, come detto, reitera l’evocazione di concetti ideali, ma privi di quella concretezza che necessita per il giudizio di responsabilità penale, impone, quindi, al giudice di merito (chiamato alla soluzione effettiva della questione) di dotarsi degli strumenti probatori sin qui richiamati, che appaiono, invero, gli unici utili.
[1] A tacere della indubbia plateale ed ingiustificata contraddizione che emerge dalla scelta di inserire in tabella I il THC, principio attivo della cannabis sia come Delta8 che come Delta9 e prevedere la cannabis in tabella II.
[2] L’accettazione anche del criterio percentuale costituisce, invece, elemento di chiarezza e stabilizzazione in sede processuale. Si pensi solo all’ipotesi tutt’altro che peregrina che la singola confezione presenti una percentuale di THC ben superiore al limite soglia dello 0,5%, ma che al contempo il peso del principio attivo risulti espresso in limiti inferiori ai 10/15 mg. . Quid iuris?
- Scarica la sentenza
Come citare il contributo in una bibliografia:
C. A. Zaina – G. Bulleri, Osservazioni a prima lettura sulla sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza penale della commercializzazione di prodotti derivati dalla Cannabis Sativa light, in Giurisprudenza Penale, 2019, 7-8