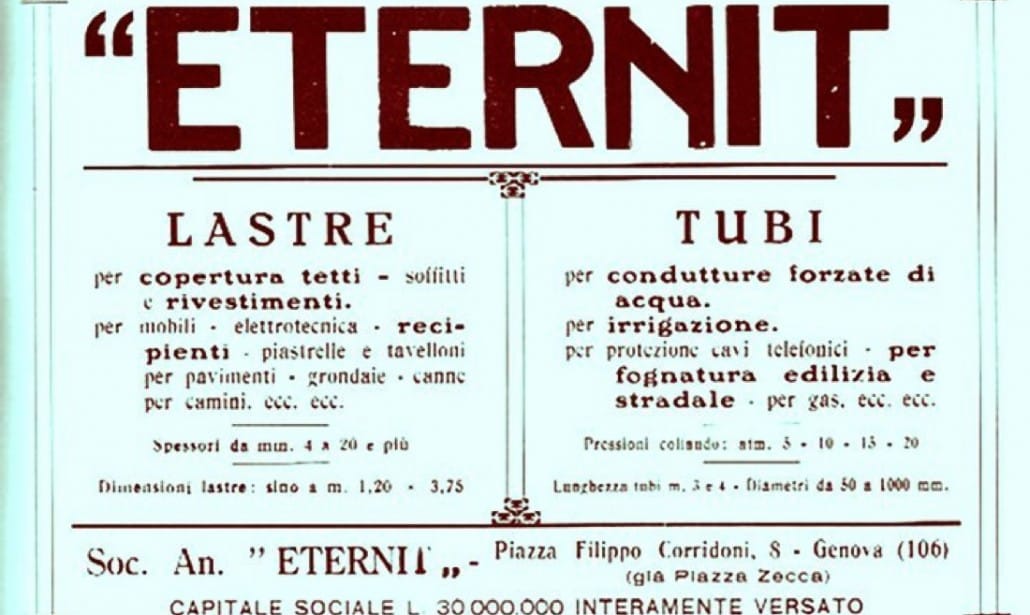La Cassazione si pronuncia in tema di estradizione verso la Turchia e rispetto dei diritti fondamentali

Cassazione Penale, Sez. VI, 16 aprile 2025 (ud. 12 marzo 2025), n. 15109
Presidente Fidelbo, Relatrice Di Nicola Travaglini
Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la sesta sezione penale si è pronunciata in tema di estradizione verso la Turchia e rispetto dei diritti fondamentali dell’estradando.
I giudici prendono le mosse ricordando come, applicandosi la normativa prevista dalla Convenzione Europea di Estradizione del 1957, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 30 gennaio 1963, n. 300, in ordine al profilo relativo alla gravità indiziaria dei delitti per i quali è stata richiesta l’estradizione, “l’autorità giudiziaria italiana pur dovendo operare una sommaria delibazione, ex art. 705 cod. proc. pen., delle ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, sulla base degli atti prodotti e del contenuto stesso della domanda estradizionale, che vi siano elementi a carico dell’estradando in ordine ai reati contestati, deve comunque valutare la determinatezza delle contestazioni e delle fonti di prova“.
Con specifico riferimento al tema del rispetto dei diritti fondamentali dell’estradando in Turchia e alla piena rispondenza agli standard internazionali del trattamento carcerario cui l’estradando verrà in concreto sottoposto (presso l’istituto penitenziario di Dumlu), “sono numerose le Autorità, nazionali e sovranazionali, che sino ad oggi si sono occupate dell’applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani nelle strutture penitenziarie turche e delle condizioni detentive degli estradandi in quel Paese“.
La Corte di cassazione – si legge nella sentenza – “ha già esaminato la questione posta dal ricorrente e altre analoghe chiarendo che, in tema di estradizione passiva verso la Turchia, devono essere valutate, in concreto, ex art. 705, comma 2, cod. proc. pen. le condizioni detentive che saranno assicurate al soggetto richiesto“.
Infatti, “dal tentato colpo di stato del 15 luglio 2016, risulta formalmente sospesa in quello Stato l’applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani in quanto il Governo della Turchia, il 21 luglio 2016, con un comunicato ufficiale al Consiglio d’Europa, ha dichiarato di avvalersi della deroga prevista dall’art. 15 della citata Convenzione, cui aderisce come Parte contraente. Inoltre, successivamente, sono state riscontrate detenzioni arbitrarie e pratiche di tortura generalizzate all’interno delle strutture penitenziarie, che determinano un livello elevato di rischio di trattamenti numani e degradanti, non per i soli detenuti politici, con limiti drastici ad una serie di diritti difensivi dell’imputato nel processo penale e con forte incremento dei poteri della polizia“.
La Corte prosegue osservando come questa situazione sia stata confermata:
– “dalla Risoluzione del Parlamento europeo dell’8 febbraio 2018 sulla situazione dei diritti umani in Turchia il cui § 6 esprime profonda preoccupazione “per le notizie di gravi maltrattamenti e torture ai danni dei detenuti e invita le autorità turche a svolgere un’indagine approfondita su tali accuse; ribadisce il suo appello alla pubblicazione della relazione del comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura (CPT)”;
– dalla comunicazione della Commissione Europea sulla politica di allargamento dell’Unione Europea del 2020 in cui si evidenzia che la Turchia si è ulteriormente allontanata dall’UE per il notevole arretramento in ordine alle regole democratiche, allo Stato di diritto, ai diritti fondamentali e all’indipendenza della magistratura e si esprime preoccupazione per il gran numero di leader dell’opposizione, attivisti per i diritti umani, giornalisti, esponenti della società civile e rappresentanti del mondo accademico arrestati e posti in custodia cautelare in virtù della legislazione antiterrorismo;
– dal rapporto della Commissione Europea sulla Turchia del 30 ottobre 2024 che al § 2.2.1 (Capitolo 23: Magistratura e diritti fondamentali) ha dato atto come la Strategia di riforma giudiziaria 2019-2023 e il Piano d’azione per i diritti umani 2021 non affrontino appieno le gravi carenze del sistema giudiziario, l’assenza di indipendenza ed imparzialità della magistratura dal potere esecutivo, la mancanza del diritto ad un giusto processo, come evidenziato peraltro nei rapporti precedenti della medesima Commissione“.
Con specifico riferimento alle condizioni carcerarie “sono state segnalate, insieme alle violazioni dei diritti umani, alle torture e ai maltrattamenti, aggravate dalla diffusa impunità per i funzionari che ne sono responsabili, anche l’uso sproporzionato della forza da parte degli agenti deputati alla sicurezza, il diverso trattamento per i detenuti politici e il divieto di contatto con i loro avvocati ed i loro parenti per anni, l’arbitrario ritardo dell’Amministrazione penitenziaria e delle Commissioni di osservazione nel rilascio condizionato dei detenuti e l’applicazione della detenzione preventiva anche per reati legati alla libertà di espressione“.
Nonostante questo quadro (acquisibile da fonti aperte e da siti istituzionali) – conclude la pronuncia – “la Corte d’appello di Roma ha escluso che l’estradando corra il concreto rischio di subire un trattamento disumano presso l’istituto penitenziario di Dulum valorizzando le indicazioni provenienti dal governo turco circa il regime cui sarà sottoposto in quella struttura, non superate da altrettanto dettagliate e mirate prove di segno contrario di organismi internazionali e associazioni relative a quel carcere“.
Ad avviso della sesta sezione, “si tratta di conclusioni che non possono essere condivise alla luce dei principi declinati dalla Corte di giustizia e da ultimo dalla sentenza del 18 giugno 2024 della Grande Sezione, sopra citata, che al § 63, proprio con riferimento alla Turchia, precisa che lo Stato membro, a fronte del dichiarato rischio di trattamenti inumani o degradanti, non può limitarsi a prendere in considerazione le sole dichiarazioni dello Stato terzo richiedente o l’accettazione, da parte di quest’ultimo, di trattati internazionali che garantiscono, in via di principio, il rispetto dei diritti fondamentali. L’autorità competente dello Stato membro richiesto deve fondarsi, ai fini di tale verifica, su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, elementi che possono risultare, in particolare, da decisioni giudiziarie internazionali, quali sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, da decisioni giudiziarie dello Stato terzo richiedente nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite (sentenze del 6 settembre 2016, Petruhhin, C-182/15, EU:C:2016:630, punti da 55 a 59, e del 2 aprile 2020, Ruska Federacija, C-897/19 PPU, EU:C:2020:262, punto 65)“.
Proprio alla luce “dell’attuale sistematica violazione della Turchia, da anni, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, per come accertata da autorità indipendenti, istituzionali e non, nei termini sopra indicati, non solo per i detenuti, ma anche per coloro che appartengono all’etnia curda o a partiti di opposizione, è necessario che la Corte di appello di Roma acquisisca elementi univoci, rispetto ad entrambi i profili, con riferimento all’odierno ricorrente“.