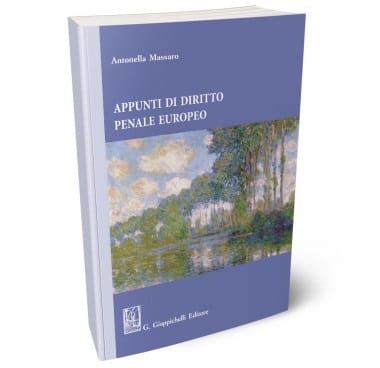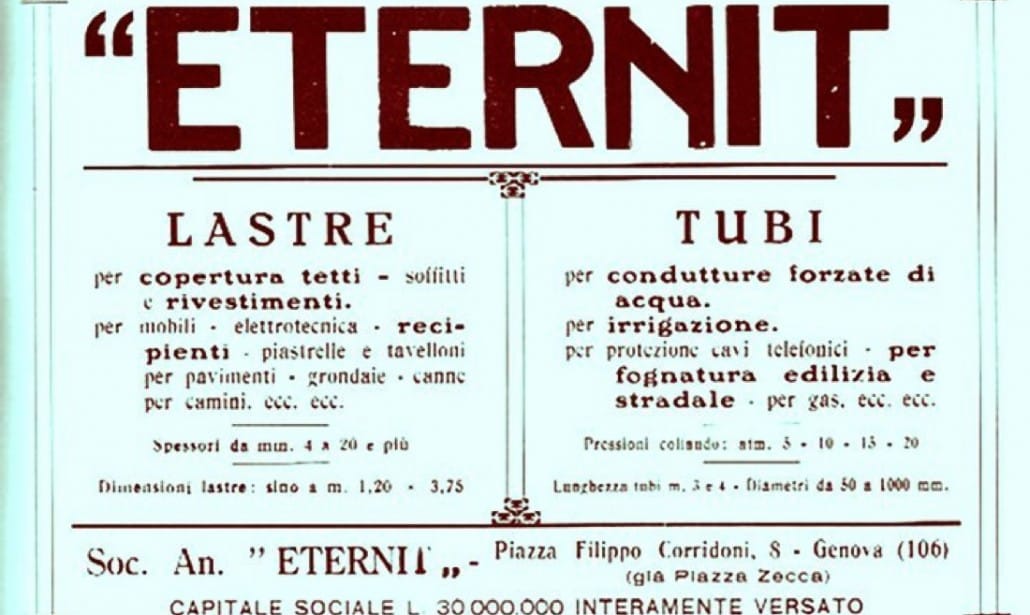Processo penale e sindacato delle scelte imprenditoriali: la Cassazione torna a pronunciarsi in tema di “business judgment rule”

Cassazione Penale, Sez. V, 7 aprile 2025 (ud. 13 febbraio 2025), n. 13299
Presidente Pezzullo, Relatore Cananzi
Segnaliamo ai lettori, in tema di bancarotta, la sentenza con cui la quinta sezione penale della Corte di cassazione è tornata a ribadire l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nel processo penale non può ritenersi operante la regola del cd. “business judgment rule“.
La doglianza di sindacato non consentito delle scelte dell’amministratore della società – si legge nella sentenza – “non tiene in conto che la Corte di appello ha fatto buon governo del principio fissato da Cassazione Penale, Sez. 5, Cimoli: ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per dissipazione, non può trovare applicazione la regola del cd. “business judgement rule” – criterio di valutazione della responsabilità civile degli amministratori della società nei confronti dell’ente, di derivazione anglosassone, secondo cui si presume che questi agiscano su base informata, in buona fede e nell’interesse della società, con esonero da responsabilità del “board of directors” purché abbia assunto decisioni corrette secondo una serie di indici di diligenza – non potendo il giudice penale sindacare, alla luce degli eventuali risultati negativi, le scelte discrezionali, pur irragionevoli, di gestione dell’impresa, fondate ragioni di carattere tecnico, economico e/o finanziario, naturalmente produttive di rischio per il suo patrimonio, quanto, invece, la prospettazione delle conseguenze della soluzione adottata, del tutto macroscopica ed abnorme, ossia manifestamente confliggente ed incoerente, secondo un giudizio “ex ante” in relazione alle dimensioni ed alla complessità dell’azienda e delle specifiche condizioni economiche sussistenti, con la tutela del ceto creditorio e con la logica di impresa“.
Dissipazione – prosegue la pronuncia – “vuol dire impiego dei beni sociali in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell’azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti“.
Nel caso in esame, “si verte in scopi estranei all’impresa perché voluttuari e personali dell’amministratore, il che esclude la richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice; correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso la fattispecie ex art. 217 di bancarotta semplice, per operazioni imprudenti, in quanto queste ultime devono risultare errate per imprudenza, ma comunque coerenti con le esigenze dell’impresa, presupposto quest’ultimo escluso nel caso in esame per l’irragionevolezza e l’estraneità dei due investimenti in imbarcazioni alle ragioni sociali“.
Come anticipato, la quinta sezione ha aderito all’orientamento già espresso in Cassazione Penale, Sez. V, 15 febbraio 2021, n. 7437 nonché in Cassazione Penale, Sez. V, 30 marzo 2023, n. 25039, secondo cui, “in merito alla propugnata violazione della “Business Judgment rule” – che il ricorrente assume essersi verificata perché sarebbe stata censurata una scelta imprenditoriale – la sentenza Cimoli si rivela preziosa per ricostruire l’istituto e la sua applicabilità nel nostro sistema penale, che il precedente in discorso ha escluso, reputandola assolutamente eccentrica rispetto alla dimensione penale“.
La business judgment rule – si legge sempre nella sentenza 25039/2023 – “discende dall’elaborazione della dottrina statunitense del diciannovesimo secolo. Essa consiste in una presunzione secondo cui gli amministratori agiscono su base informata, in buona fede e nell’interesse della società, con la conseguenza di esonerare da responsabilità il board of directors purché abbia assunto decisioni corrette, valutate attraverso una serie di fiduciary duties quali: the duty of care; the duty to monitor; the duty to inquiry; the duty of loyalty. Nei casi in cui gli amministratori abbiano assunto una decisione qualificabile come ragionevole/razionale, al verificarsi di risultati negativi, essi saranno affrancati da eventuali responsabilità, poiché titolari di una certa discrezionalità nel decidere sull’opportunità di un progetto“.
Deve convenirsi con la sentenza Cimoli – osservavano i giudici di legittimità già nel 2023 – “quando ha sostenuto che la regola statunitense non può essere traslata in ambito penalistico, essendo maturata in un contesto risarcitorio, tipicamente civilistico; quello che segna la differenza tra le valutazioni del giudice civile e quelle del giudice penale è che l’interprete deve sia valutare la prospettiva che si stagliava agli occhi dell’agente ex ante, ma anche il danno che la sua scelta ha poi determinato sul patrimonio sociale una volta intervenuto il fallimento (o la dichiarazione di stato di insolvenza). In altri termini, ciò che in sede penale va accertato e se l’agente abbia previsto come possibili determinati esiti e conseguenze della propria scelta e della propria conseguente condotta, accettando la loro verificazione, anche nella consapevolezza del danno che gli stessi potevano arrecare alla garanzia dei creditori e abbia, ciò nondimeno, agito“.
Rilevano penalmente “non le scelte semplicemente irragionevoli o inopportune sotto il profilo tecnico (opportunità la cui valutazione non è appannaggio del giudice penale), ma quelle integralmente e manifestamente configgenti ed incoerenti con la tutela del ceto creditorio e con la logica di impresa, tenuto conto del concreto contesto di riferimento sottoposto al giudicante, anche in relazione alle condizioni economico-finanziarie dell’impresa, e, quindi, la conseguente capacità predittiva circa l’incidenza delle sue scelte sulla tenuta del patrimonio aziendale in funzione di garanzia“.
In conclusione, facendo proprie ulteriori argomentazioni della sentenza Cimoli, “non può che esulare da ogni valutazione di discrezionalità ed opportunità quella condotta che, con giudizio ex ante, si ponga in drastico ed irrimediabile conflitto con la funzione di garanzia patrimoniale dei beni dell’impresa, unica ottica rispetto alla quale il giudice penale può e deve valutare la coerenza delle scelte imprenditoriali con le finalità dell’impresa“.